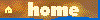Per
un programma di politica economica
di
Giorgio Lunghini
maggio
05
Cominciamo
dal principio, dal contesto internazionale e dalla storia recente
dell'economia italiana. L'economia dell'Occidente è dominata
dall'economia degli Stati Uniti d'America, ma le ragioni di questo dominio
non sono strettamente economiche. Se il Fondo monetario internazionale
mandasse i suoi ispettori alla Casa Bianca, imporrebbe agli Usa riforme
ben più severe di quelle imposte dagli Usa ai paesi sudamericani o
asiatici; e se le società di revisione ne controllassero i conti, il
punteggio sarebbe deprimente. In verità, nel luglio scorso, il FMI aveva
diffuso un rapporto in cui si manifestavano serie preoccupazioni per le
dimensioni dei deficit commerciale e di bilancio degli USA, tali che
potrebbero portare a un indebitamento estero pari al quaranta per cento
del prodotto interno, con conseguenti attacchi al dollaro, aumento dei
tassi di interesse e quindi recessione. Il New
York Times ha però riferito che i portavoce della Casa Bianca hanno
liquidato il rapporto come allarmista, dicendo che Bush si era impegnato a
dimezzare il deficit nei prossimi cinque anni.
Per
ora il prodotto interno lordo degli Stati Uniti cresce, ma di questa
crescita si devono ricordare le condizioni e le conseguenze. Le condizioni
sono le stesse che consentono agli Usa il dominio dell'economia
occidentale: la licenza che si possono concedere, poiché nessuno la può
sanzionare, di un indebitamento crescente, privato e pubblico, all'interno
e verso l'estero. Gli Stati Uniti non hanno nessun patto di stabilità da
rispettare e si possono consentire un keynesismo militare di grande
efficacia quantitativa, tramite la spesa pubblica nel comparto
militare-industriale e le innovazioni tecnologiche conseguenti.
Innovazione tecnologica che è una componente importante della crescita
della produttività del lavoro americano; crescita della produttività che
però non si trasforma in maggiore occupazione, in salari più alti e in
migliori condizioni di vita per l'americano medio. Questo modello
americano non può funzionare a lungo. Le prospettive di deflazione
(paventate da molti, io tra questi) non sono affatto irrealistiche.
Circa
l'Italia (qui salto il termine medio, l'Europa, poiché richiederebbe un
discorso a parte e conseguente), si dovrebbe ragionare su una questione
liquidata in fretta: se l'economia italiana sia in declino. Sì,
l'economia italiana è in declino; questo governo ha gravemente accelerato
la tendenza, ma non ne è l'unico responsabile; le ferite recenti saranno
difficili da medicare, e le politiche economiche che dovranno essere
adottate dovranno essere determinate e dure. Che l'economia italiana sia
in una stagione di declino, non in una fase di rallentamento
congiunturale, l'aveva raccontato per filo e per segno Pierluigi Ciocca,
in una relazione che suscitò scandalo poiché diceva la verità e che qui
riprendo per ricordarci quali sono le condizioni iniziali di qualsiasi
progetto.
L'economia
italiana si è sviluppata a ritmi sostenuti dal dopoguerra ai primi anni
settanta, poi ha prevalso una tendenza al rallentamento del reddito
(assoluto, pro capite, effettivo, potenziale), dei consumi, della
produttività, delle esportazioni. Dopo il primo trimestre del 2001
l'espansione dell'attività produttiva è stata quasi nulla: la più lunga
fase di ristagno dal dopoguerra. Superamento di un ritardo storico nello
sviluppo, shock salariali e petroliferi, squilibri del settore pubblico,
instabilità macroeconomica possono dare ragione del rallentamento negli
anni settanta e ottanta; meno agevole è spiegare l'insoddisfacente
prestazione successiva. Gli aspetti più preoccupanti sono la produttività
e le esportazioni. Il rallentamento nella produttività del lavoro, che
pure è elevata, è scaturito dalla minor crescita della produttività
totale dei fattori; conferma, questa, di una economia strutturalmente meno
capace di impiegare e organizzare il lavoro, innovare, applicare il
progresso tecnico.
Dal
lato della domanda aggregata il rallentamento è dovuto al minor
contributo dei consumi privati e pubblici, non compensato da esportazioni
che invece hanno perduto quota nel mercato mondiale. Il limite dei
prodotti italiani è anche nei prezzi alti, ma soprattutto nella qualità,
nella composizione merceologica, in un modello di specializzazione
invecchiato. Un sostegno alla crescita, che ne ha evitato un rallentamento
ancora più grave, è venuto dall'accumulazione di capitale, che nel corso
del decennio è migliorata quanto a composizione. È tuttavia mancato un
balzo all'insù degli investimenti, segnatamente in ricerca
e sviluppo, nonostante ve ne fossero i mezzi finanziari, a
cominciare dai profitti non distribuiti. Gli imprenditori italiani non
amano il rischio. La decelerazione del prodotto pro capite riflette anche
il basso tasso di occupazione del lavoro. La disponibilità di risorse
umane utilizzabili ma non utilizzate è ampia, per la prima volta anche
grazie all'immigrazione. Dati i livelli della produttività del lavoro, è
il più basso impiego del lavoro a far scendere l'Italia nelle classifiche
del Pil per abitante.
È
divenuto, ed è ancora molto elevato il debito pubblico: gravosissimo
lascito di una lunga stagione di irresponsabilità politica e finanziaria
che lo raddoppiò rispetto al Pil (dal 60 al 125%) fra il 1981 e il 1995.
Dal debito pubblico è derivato, e deriva, un impedimento alla crescita,
prima perché l'alto prezzo del denaro penalizzava gli investimenti, poi
perché generava aspettative che deprimono la propensione a investire. Di
qui anche lo stato delle infrastrutture materiali, che non sono state
potenziate, si sono deteriorate, e sono inferiori per quantità e qualità
a quelle di altri paesi europei. Ciò è vero anche per importanti
strutture immateriali. L'ordinamento giuridico dell'economia, cruciale per
la crescita, si è dimostrato sempre meno adeguato, nelle norme e nella
loro applicazione. Questo può dirsi per il diritto societario,
fallimentare, del processo civile, per alcuni aspetti del diritto del
lavoro. Le riforme in tale campo, che di per sé non costano, stentano.
L'intelligenza necessaria per un nuovo organico diritto dell'impresa è
ostacolata dagli scarsi raccordi della cultura economica con quella
giuridica e dagli interessi costituiti, quando non anche strettamente
privati.
La
frammentazione del sistema delle imprese e l'incapacità della piccola
impresa di accrescere la propria dimensione si sono accentuate:
all'impresa italiana, miope, conviene restare piccola. Ciò però
restringe gli investimenti diretti all'estero, limita le esportazioni,
impedisce una formazione non servile dei lavoratori, colloca a livelli
bassissimi la spesa privata per la ricerca e l'innovazione tecnologica.
Nonostante l'ampia apertura verso l'estero, all'interno dell'economia
italiana la concorrenza è diminuita. Il sostegno collusivo della spesa
pubblica, la cedevolezza del cambio, la dinamica salariale accomodante
hanno indebolito le sollecitazioni all'efficienza e alla innovazione.
L'irresponsabile
smobilitazione dell'impresa pubblica, rispetto alla alternativa di una sua
gestione corretta ed efficiente, ha fatto venir meno un potenziale ed
efficace concorrente e dunque uno stimolo all'impresa privata. Sulla scena
internazionale i mutamenti nei vantaggi comparati hanno configurato,
insieme con l'opportunità di accedere a mercati di sbocco potenzialmente
vasti, specifici rischi per gli assetti esistenti del sistema produttivo
italiano. Da un lato si sono affermati nuovi partner commerciali (Cina e
India dopo le `tigri asiatiche', ad esempio), propensi a esportare beni di
consumo che l'Italia produce e a importare beni capitali che l'Italia non
produce. Dall'altro lato si sono rafforzate economie, come quella degli
Stati Uniti, che offrono prodotti caratterizzati da economie di scala,
R&S, innovazione. Il modello di specializzazione dell'Italia è quindi
divenuto vulnerabile dall'alto e dal basso.
Infine
la distribuzione del reddito: la sperequazione nella distribuzione per
classi, tra persone e nel territorio, già alta nel confronto con altri
paesi industriali, si è ulteriormente accentuata. Oltre che iniquo, ciò
è dannoso, poiché ha concorso a frenare la crescita, limitando l'accesso
dei più poveri ai consumi, in particolare a quelli a maggior contenuto
culturale, e alla formazione del risparmio nazionale. Una buona parte dei
cittadini, soprattutto nel Mezzogiorno, non ha le risorse necessarie per
investire in capitale umano, su se stessi e sui figli. Il quadro è
aggravato da una mobilità sociale comparativamente bassa, invariata tra
le generazioni, addirittura diminuita tra le professioni e le carriere.
Dal
quadro che ho tracciato sopra si possono desumere non poche delle molte
cose che si dovranno fare, se si conviene che la crescita sia un problema.
Non pochi, a sinistra, su ciò non convengono. Io però non credo che
nelle condizioni attuali si possa auspicare lo stato stazionario: la
società italiana ha tali e tanti bisogni insoddisfatti, individuali e
collettivi, presenti e futuri, da richiedere un'economia in primo luogo
giusta, ma che proprio per questo deve essere efficiente, capace di
produrre un sovrappiù. Questo sovrappiù deve essere distribuito in
maniera equa, e qui si pone la questione di una politica di
redistribuzione del reddito e della ricchezza.
Gli
squilibri attuali tra salari, profitti e rendite sono intollerabili e
devono essere rimossi. Una redistribuzione della ricchezza e del reddito,
ma ottenuta con una politica fiscale opposta rispetto a quella sulla quale
sembra esserci oggi un demagogico consenso tra sinistra e destra (`meno
tasse'), è un obiettivo irrinunciabile. Tuttavia vi è un ottimismo
eccessivo circa la possibilità che essa sia anche lo strumento principale
di una politica di rilancio dell'economia su un sentiero di crescita
stabile e duraturo. È vero che in presenza di aspettative non
pessimistiche una redistribuzione del reddito dai ricchi ai poveri,
realizzata mediante un'imposizione fiscale progressiva e particolarmente
severa nei confronti della rendita, porta a un aumento della domanda per
consumi. La propensione marginale al consumo dei poveri è maggiore di
quella dei ricchi, dunque uno spostamento dalle rendite e dai profitti ai
salari farà aumentare la propensione marginale media al consumo. Tuttavia
i consumi sono soltanto una delle componenti della domanda effettiva, e
non la più importante ai fini di una crescita sostenuta: più importanti,
da questo punto di vista, sono gli investimenti e le esportazioni.
Con
l'avvento dell'Unione europea gli spazi potenziali di una politica
economica e sociale comune si sono ampliati, ma con la contestuale
rinuncia alla leva monetaria gli strumenti di cui dispongono gli Stati
nazionali si sono ridotti. A livello europeo, d'altra parte, prevale una
visione pre-keynesiana del ruolo della moneta, prevale quella Treasury
view contro cui si batteva Keynes nei primi anni trenta. Di qui il
Patto di stabilità e dunque, di fatto, l'interdizione di politiche di
spesa pubblica lungimiranti e di ammontare significativo. Quel patto era
sbagliato, ma è stato allentato per le ragioni sbagliate: perché quasi
tutti i paesi europei hanno problemi di bilancio, e non in vista di un
grande programma europeo di investimenti pubblici. C'è dunque anche un
problema di cultura economico-politica.
Gli
strumenti che rimangono ai governi nazionali sono l'imposizione fiscale e
la produzione legislativa, strumenti potentissimi ai fini di una
programmazione dello sviluppo economico e sociale. Sì, programmazione:
non bisogna avere paura delle parole. La politica del laissez faire non è forse una politica di programmazione, però
esercitata da una parte sola della società? (Voi ricordate l’origine
del motto “laissez faire”. Quando
Colbert chiese al mercante Legendre “Que
faut-il faire pour vous aider?”, la risposta di Legendre fu: “Nous laissez faire”.)
Dell'imposizione fiscale ho già detto per quanto riguarda la
redistribuzione del reddito. Più in generale, una revisione complessiva
del sistema fiscale come strumento di politica economica, dovrebbe tornare
a essere tra i primi impegni di un governo nuovo. La portata dell'altro
strumento che ho nominato, la produzione legislativa, è spesso
sottovalutata. Qui un governo nuovo dovrebbe imparare da quello attuale,
ovviamente rovesciandone il segno.
I
problemi di cui stiamo parlando sono problemi di lungo periodo, dunque il
Keynes che ci può interessare non è il Keynes del breve periodo; è,
semmai, il Keynes dell'ultimo capitolo della Teoria generale, sulla ‘filosofia sociale’ cui questa potrebbe
condurre. Qui Keynes pone tre questioni, che a me paiono proprio quelle
all'ordine del giorno: la piena e buona occupazione, una distribuzione più
uniforme della ricchezza e del reddito, un sistema economico e sociale
capace di produrre anche ciò che il capitale non trova conveniente
produrre. Le tre questioni si riducono a una: una democrazia economica
compiuta. Io credo che queste tre questioni dovrebbero e potrebbero
rappresentare le coordinate entro cui disegnare un programma economico e
sociale che trovi il consenso dei lavoratori e che dunque sia la base di
un compromesso serio tra le forze politiche e sociali della sinistra. È
un disegno ambizioso, ma basterebbe assumerlo come riferimento concettuale
e politico e come vincolo: ogni singolo provvedimento di politica
economica e sociale dovrebbe tendere, o almeno non contravvenire, a
quell'obiettivo.
In
Italia il problema della piena occupazione riguarda oggi il Mezzogiorno,
il problema della buona occupazione riguarda tutto il paese. Le rovinose
riforme del mercato del lavoro vanno riformate, e ciò cominciano a
pensare anche non pochi imprenditori: il lavoro precario sembra costare
meno, ma rende anche meno. In questa stessa prospettiva va posto il
problema della formazione e della ricerca, anche ai fini di una maggiore
efficienza economica: la soluzione va cercata nella scuola (pubblica) e
nell'Università. Oggi si vorrebbe che la scuola e l'Università si
trasformassero in un'azienda al servizio delle imprese. Invece la
riduzione della scuola e dell'Università a strumento mercantile non
sarebbe affatto nell'interesse delle stesse imprese; per non parlare della
questione davvero importante, cioè della libertà della cultura e della
scienza.
Nelle
prospettive attuali della scienza e della tecnologia, e nelle condizioni
attuali del lavoro - per brevità: in un mondo post-fordista - la cultura
e le conoscenze tecniche richieste non sono affatto di tipo specialistico.
Occorrono invece solide basi culturali, e l'unica cultura solida è una
cultura critica; e occorre che gli studenti, nella scuola e nell'Università,
imparino a studiare e a imparare, non a fare. A fare impareranno poi,
facendo, nel mondo del lavoro. Contro gli apologeti della formazione,
basta un argomento: se davvero dovremo prepararci a cambiare mestiere
cinque o sei volte nella nostra vita, per evitare che si torni al travail
sollicité, cioè alla corvée,
occorrerà non una scuola che insegni mestieri, ma una scuola che insegni
a studiare e a imparare. La sede naturale della ricerca scientifica e
tecnologica di base, d'altra parte, è l'Università. Fuori dalla
Università, la ricerca, salvo rare eccezioni, è mero calcolo di
convenienza e adattamento aziendale delle tecniche di produzione
disponibili. Anche di questo sono consapevoli non pochi imprenditori (il
vero problema è che sono pochi i veri imprenditori).
La
dimensione ideale di una politica di piena e buona occupazione è
naturalmente quella europea (era così anche nella sua tradizione
migliore). Ricordo, a questo proposito, che ce ne sarebbero le premesse:
l'Unione europea è un sistema quasi chiuso, poiché il grosso degli
scambi commerciali avviene tra i paesi che ne fanno parte. Ricordo anche
che l'assunzione di una prospettiva di piena occupazione sarebbe più
favorevole alla pace di quanto non sia un sistema teso alla conquista dei
mercati altrui: il commercio internazionale cesserebbe di essere quello
che è ora, ossia un espediente disperato per preservare l'occupazione
interna forzando le vendite sui mercati esteri e limitando gli acquisti -
metodo che semplicemente sposta il problema della disoccupazione sul
vicino che ha la peggio nella lotta - ma sarebbe uno scambio volontario e
senza impedimenti di merci e servizi, in condizioni di vantaggio
reciproco.
Circa
la redistribuzione del reddito per via fiscale, è in primo luogo
necessaria una lotta decisa all'evasione e alla elusione. Aggiungo che il
luogo comune, secondo cui le imposte di successione provocherebbero una
riduzione della ricchezza capitale del paese, è infondato. Oltre che
garantire il principio (liberale) dell'eguaglianza dei punti di partenza,
alte imposte di successione favorirebbero l'accumulazione di capitale,
anziché frenarla. Occorrerà fare una scelta tra le tre grandi classi di
reddito: salari, profitti e rendita, che oggi è eminentemente rendita
finanziaria. L'istigazione keynesiana alla eutanasia del rentier
non ha presupposti moralistici, ma strettamente economici: la rendita
taglieggia l'accumulazione di capitale produttivo, contrasta l'eventuale
crescita dell'occupazione, si appropria dei guadagni di produttività e
distorce i modelli di consumo. Profitto e rendita sono intrecciati,
tuttavia il profitto può sopravvivere senza rendita, mentre non è vero
il contrario. Questo, in un certo senso, è un problema politico interno
al capitale, ma è anche un grande problema politico della sinistra.
E
qui c’è una questione, analoga a quella dell’ordinamento delle
successioni, anche questa di ordine fiscale e legislativo, su cui si dovrà
ragionare. Molti lavoratori hanno investito in titoli il loro risparmio da
lavoro, ma non per questo sono dei rentier,
né in tal modo compromettono il processo di accumulazione. Al contrario.
Diversa è la posizione e la responsabilità del capitalista che impiega i
profitti nella speculazione finanziaria – che è un gioco a somma zero.
È davvero impensabile una qualche forma di nominatività delle proprietà
finanziarie, tale da consentire un trattamento fiscale differenziato?
La
terza questione, la struttura dell'offerta, è in sostanza quella dei
rapporti tra settore pubblico e settore privato. Per il settore privato il
problema centrale è la competitività sui mercati internazionali, e
premessa della competitività è una politica industriale reale. È
l'esatto contrario delle politiche di svalutazione competitiva, ora
impossibili, ma di cui l'industria italiana ha vissuto per troppi anni;
politiche che hanno confinato l'economia italiana nella posizione del
produttore al quale ci si rivolge quando c'è un picco di domanda
internazionale temporaneamente insoddisfatta, ma che è incapace di
vendere alle proprie condizioni e in quantità prevedibile in precedenza
le proprie merci. L'aumento della competitività, in una prospettiva di
lungo periodo, non passa per una riduzione del costo del lavoro. Sarebbe
impossibile ridurre i costi del lavoro italiani al livello dei paesi meno
sviluppati, né sarebbe accettabile ridurre a quel livello i salari per
via indiretta, operando attraverso una riduzione dei servizi sociali,
della stabilità del posto di lavoro, della previdenza, delle spese per
l'istruzione e per la cura della persone. I bassi salari non sono la
risposta alla disoccupazione: è la disoccupazione che costringe i
salariati ad accettare lavori precari e poco remunerati. In generale gli
imprenditori che pagano poco la forza lavoro dirigono imprese inefficienti
o marginali, e cercano di compensare in questo modo la loro
inefficienza.
Non
c'è industria senza un piano. (Sfortunatamente la sinistra italiana è
divisa anche su questo punto: una parte di essa non crede nell'industria,
l'altra non crede nel piano.) Qui può e deve avere un ruolo importante la
riscoperta e la riproposta dell'impresa pubblica. Nel nostro paese
l'impresa pubblica ha una grande storia, e l'uso corrotto che pure ne è
stato fatto in passato non diminuisce l'importanza che essa potrebbe avere
in futuro. `Imprenditore pubblico' non è un ossimoro, mentre c'è da
chiedersi che razza di `imprenditori' siano quelli che, grazie alle
privatizzazioni, si trovano ora nella remunerativa e tranquilla nicchia
del gestore privato di servizi pubblici. L'impresa pubblica può
permettersi strategie industriali che l'impresa privata, soprattutto la
piccola e media, non può permettersi. In particolare può darsi orizzonti
temporali lunghi, e dunque può costituire, per l'industria privata, un
fattore di indirizzo, sostegno e stimolo concorrenziale.
Più
in generale il settore pubblico può e deve fare ciò che il settore
privato, per ragioni di convenienza economica di breve periodo,
semplicemente non fa. A questo proposito Keynes, che non era un bolscevico
(sebbene Einaudi lo pensasse), parla addirittura di “una socializzazione
di una certa ampiezza dell'investimento”. Il criterio è semplice e
convincente: dobbiamo tendere a separare quei servizi che sono
tecnicamente sociali da quelli che sono tecnicamente individuali. L'azione
più importante dello stato si riferisce non a quelle attività che gli
individui privati svolgono di già, ma a quelle funzioni che cadono al di
fuori del raggio d'azione degli individui, a quelle decisioni che nessuno
prende se non vengono prese dallo stato. La cosa importante per il governo
non è fare ciò che gli individui fanno di già, e farlo un po' meglio o
un po' peggio, ma fare ciò che altrimenti non si farebbe. Sta in questo
la supremazia dello stato sociale, rispetto allo stato minimo.